
di Domenico A. Cassiano
Il compianto Giovanni Russo, nel recente Carlo Levi segreto (ed. B.C. Dalai, 2011), ritorna sull’utopia della “civiltà contadina” che proprio in Levi ebbe il suo cantore ed un interprete autentico in Rocco Scotellaro, poeta e sindaco socialista di Tricarico, per rilevare l’attualità del pensiero di Levi e della “questione meridionale”, non ancora risolta ed – anzi – aggravatasi in questi ultimi anni. Certo, oggi il Sud non è più quello conosciuto negli anni Trenta del secolo scorso da Carlo Levi, confinato dal regime fascista in uno sperduto paese della Basilicata.
Una valutazione superficiale potrebbe erroneamente fare ritenere che lo squilibrio fondamentale, che affligge il Meridione, sia dato soltanto dal pauroso decremento demografico degli insediamenti montagnosi e collinari e dal rigonfiamento oltre misura dei paesi di pianura, soprattutto, di quelli marini. Ma, se si guarda più in profondo, ci si accorge che la “scomparsa” del mondo contadino ha lasciato un vuoto culturale, ormai incolmabile; ne consegue che la disgregazione sociale ne caratterizza lo sottosviluppo, oggi più grave rispetto al passato, per la carenza di “quell’equilibrio culturale che si reggeva proprio sulla tradizione millenaria di un mondo contadino ora quasi totalmente dissolto” (pag. 22).
Ancor prima del confino ad Aliano, in Basilicata, – sottolinea giustamente il Russo – Levi era “impregnato” di cultura meridionalistica; aveva letto Salvemini, Giustino Fortunato, Gramsci, Nitti, Croce; aveva discusso i temi della questione meridionale con Piero Gobetti, fondatore della rivista La rivoluzione liberale, del cui comitato di redazione era componente. Dalla sua esperienza di confino e, quindi, dalla conoscenza diretta di persone e cose, matura la convinzione della divisione della realtà politica e sociale meridionale fondamentalmente in due categorie o gruppi sociali: i luigini (dal nome Luigi del podestà di Aliano) ed i contadini. I primi simboleggiano complessivamente la borghesia rurale meridionale, ceto perlopiù parassitario, che viveva alle spalle dei contadini, asservita al potere politico dominante quale che esso sia (borboni, Savoia, fascisti); i secondi costituivano la stragrande maggioranza della popolazione che viveva, come appartata, una sua vita autonoma, indifferente alle sorti dello Stato, avvertito e sopportato come ostile, emanazione e strumento di oppressione da parte di lor signori.
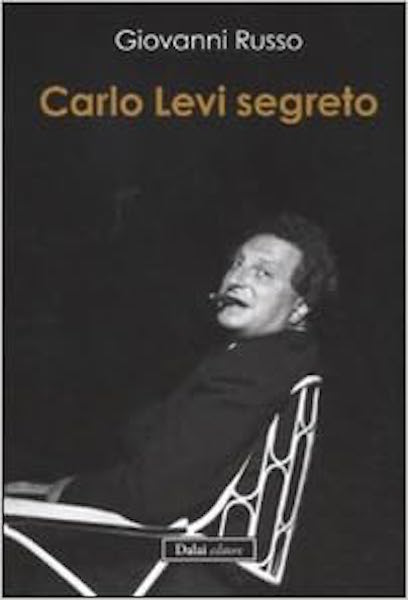
Antistatalismo contadino e statalismo dei “galantuomini” o luigini asserviti al potere politico dominante costituiscono le due componenti essenziali della questione meridionale. Che non è un puro problema economico, di opere pubbliche, di colonizzazione o una eredità storica da eliminare con l’esercizio del liberalismo oppure la risultante dell’oppressione capitalistica, superabile con la dittatura del proletariato. La soluzione della questione meridionale non va ricercata in interventi dall’alto ed in provvidenze piovute dallo Stato. Perché – secondo Levi – “non può essere lo Stato a risolvere la questione meridionale per la ragione che quello che noi chiamiamo problema meridionale non è altro che il problema dello Stato. Fra lo statalismo fascista, lo statalismo socialista, lo statalismo liberale e tutte quelle alte forme di statalismo che in un paese piccolo borghese come il nostro cercheranno di sorgere, e l’antistatalismo dei contadini, c’è e ci sarà sempre un abisso, e si potrà cercare di colmarlo soltanto quando riusciremo a creare una forma di Stato, di cui anche i contadini si sentono parte. Le opere pubbliche, le bonifiche sono ottime ma non risolvono il problema…I piani centralizzati possono portare grandi risultati pratici, ma sotto qualunque segno resterebbero due Italie ostili”.
Giovanni Russo, a tale proposito, non tralascia dall’evidenziare il “fondamento di attualità e verità di queste considerazioni”. Fra lo Stato ed il Mezzogiorno non è stata sanata l’antinomia, determinata all’indomani dell’unità nazionale dalla scelta di privilegiare l’industrializzazione del Nord, trascurando – come, invece, sarebbe stato estremamente necessario – dall’intervenire nelle campagne meridionali per spezzare il reticolato del latifondo, assai dannoso perché, mantenendo l’immobilismo e lo sfruttamento parassitario, rendeva impossibile lo sprigionarsi di quelle forze nuove e intraprendenti, che avrebbero potuto certamente mutare in meglio la situazione sia sotto il profilo economico che sociale e politico.
Il mancato intervento riformatore nel Sud, pure autorevolmente ipotizzato dalla Commissione Parlamentare Massari, e la scelta della repressione poliziesca indiscriminata hanno avuto effetti altamente negativi nello sviluppo della storia nazionale, che ancora oggi pesano; non passa giorno che la stampa ed i media non riportino le ricorrenti strampalate volgarità del sottoproletariato leghista e di certi suoi dirigenti che addirittura ricoprono rilevanti cariche nel governo nazionale.
In questi ultimi tempi, vanno diffondendosi interpretazioni “giornalistiche” sulla storia postunitaria del Mezzogiorno, fatte passare come “scoperte” e come mirabolanti rivelazioni, fondate sull’erroneo presupposto dell’opera mistificatrice e falsificatrice svolta dalla storiografia ufficiale, che avrebbe di proposito trascurato dal mettere in luce il brigantaggio e le lotte contadine. Sull’argomento, invece, esiste un’abbondante ed esaustiva bibliografia ad iniziare dai primi anni dopo la conquista dell’Unità nazionale, che ha fatto luce sulle ragioni di profondo malessere sociale nelle campagne, da cui si originava e si alimentava il fenomeno del brigantaggio, nonché sulla necessità di un intervento riformatore che, tuttavia, non fu ritenuto urgente perché l’emergenza imponeva la repressione. Ma “la verità è – annota Giovanni Russo – che dopo l’Unità i drammi del Mezzogiorno non furono risolti anche perché, come hanno dimostrato storici eminenti tra cui Rosario Romeo, per creare una nazione a livello europeo fu indispensabile favorire l’industrializzazione del Nord, pagata a duro prezzo dal Mezzogiorno”.
Nel villaggio lucano di Aliano, Carlo Levi aveva intuito che l’autonomia del mondo contadino con i suoi “legami con le radici italiane più antiche” era una cultura, un sistema di vita con suoi valori universali, che non portava al settarismo e non aspirava alla secessione, anche se si collocava al di fuori dello Stato, ne diffidava e ne avvertiva l’avversità. Almeno fino ai primi anni del secondo dopoguerra quando una pagina inedita di consenso e di fiducia nella autorità pubblica fu scritta dalle popolazioni rurali del Mezzogiorno, come dimostra la storia di quel periodo, perché si avvertiva la solidarietà attiva della dirigenza del movimento democratico e dei governi della coalizione antifascista (1944-47) con le rivendicazioni di riforma agraria e di una nuova, moderna e democratica organizzazione statale.
Si vide, allora, quale grande forza di liberazione e di rinnovamento effettivo e concreto costituivano le masse rurali del Mezzogiorno che dalla Sicilia, dalla Calabria, Lucania e dalla Puglia si mossero contemporaneamente per rivendicare le terre e migliori condizioni di vita, diventando protagoniste nella lotta per la “rinascita del Mezzogiorno” e così assurgendo a classe generale che si faceva carico della necessità ed urgenza di un nuovo e moderno assetto politico e sociale del Sud. Erano, insomma, le masse contadine che dimostravano nei fatti di potere fare quella rivoluzione meridionale, che il notabile di Avellino, Guido Dorso, aveva inutilmente profetizzato come opera e come missione della borghesia meridionale, rivelatasi invero classe inetta, parassitaria, in genere composta da quei luigini inconcludenti, sui quali – e giustamente – non si è risparmiata la fine ironia di Carlo Levi.
La lotta dei contadini ebbe una sua particolare rilevanza perchè, come ha osservato Piero Bevilacqua, “servì a piegare resistenze conservatrici influenti, ancora vive e diffuse nella società meridionale e italiana di allora (provenienti in genere dalla proprietà terriera, ma anche dal mondo della magistratura e delle professioni ancorato a posizioni conservatrici, quanto non reazionarie). Era infatti il loro ingresso nella lotta politica, insieme a quello dei lavoratori delle città, a rendere in qualche modo operante e viva la democrazia”.
L’intuizione di Carlo Levi aveva identificato nel mondo contadino quella forza rivoluzionaria che avrebbe potuto – se opportunamente guidata – contribuire alla effettiva trasformazione democratica dell’Italia, attuando i principi della Costituzione repubblicana, completando gli ideali risorgimentali. Ma così non fu perché il poderoso movimento, che immetteva nella storia un popolo senza storia, fu utilizzato e si disperse in inutili “rivoluzioni” locali, come quelle di Caulonia, in Calabria, o di Irsina e Pisticci, in Lucania; in vere e proprie inconcludenti rivolte con l’assalto ai municipi, ai palazzi baronali con l’omicidio di proprietari. Neppure ebbe fortuna il tentativo dei comunisti di indirizzare la protesta contadina secondo le indicazioni gramsciane dell’unità dei contadini del Sud e degli operai del Nord perché il partito comunista, in ossequio alla divisione di Yalta fra le grandi potenze, non poteva turbare gli equilibri politici italiani. La pressione contadina fu, quindi, utilizzata per singoli obiettivi e non per la radicale e reale trasformazione dello Stato attraverso l’attuazione di quelle riforme democratiche, da tempo auspicate.
Secondo Giovanni Russo, il freno al movimento contadino fu dovuto a motivi diversi, ma è da ritenere che prevalente fu la scelta della dirigenza comunista di non accentuare gli aspetti classisti e di insistere soprattutto nella ricerca e messa in atto di una politica di alleanze “di tipo solidaristico”, ma di fatto interclassista, che accomunasse quanti più strati sociali era possibile intorno all’obiettivo di una invero generica “rinascita del Mezzogiorno”.
In effetti, gli organismi dirigenti comunisti, a causa delle implicazioni internazionali e nazionali, al fine di evitare il rischio dello scontro sociale, erano determinati – come ha rilevato Sidney G. Tarrow in Partito comunista e contadini del Mezzogiorno – all’abbandono di una politica classista ed a scegliere una strategia interclassista e solidaristica, mettendo tra parentesi l’ipotesi gramsciana dell’alleanza tra contadini del sud e classe operaia del nord. Ovviamente contraria era la posizione di Carlo Levi, radicalmente contrastata soprattutto da Mario Alicata che vi scorgeva gli elementi di un pericoloso estremismo in opposizione al realismo politico togliattiano, rigido nell’osservanza degli accordi di Yalta e attento a non turbare gli equilibri internazionali che avevano destinato l’Italia nel blocco occidentale.
Non senza contrasti passò tale linea all’interno del partito comunista. Una eco la si rinviene negli scritti sulle lotte per la terra in Calabria di Paolo Cinanni, allora un dei maggiori dirigenti comunisti in Calabria, che fa esplicito riferimento alla polemica con Alicata in Calabria ed in seno alla Commissione agraria nazionale. Mario Alicata, inviato dalla Direzione nazionale in Calabria come segretario regionale in sostituzione di Fausto Gullo, conosciuto allora come “ministro dei contadini”, s’era fatto promotore nella regione di una politica di alleanze che, in effetti, portava paradossalmente anche all’inclusione nel fronte progressista degli stessi “galantuomini” ossia dei luigini di Levi, che erano, poi, i veri rappresentanti del trasformismo meridionale.
Secondo Cinanni, era grave l’errore di Alicata perché i “galantuomini” diventavano il “tramite della penetrazione del trasformismo meridionale nel nostro partito” e,molto spesso, essi erano gli usurpatori delle terre pubbliche contro cui lottavano i contadini; per conseguenza, l’alleanza con loro non poteva che essere antitetica, impossibile e fuorviante, destinata a svuotare del loro significato le lotte contadine.
Ma, se da parte marxista, severa era la critica di Alicata, non meno decisa era quella di parte liberale dalle pagine della rivista Nord e Sud, diretta da Francesco Compagna, e democristiana in persona di Pasquale Saraceno e, poi, degli stessi comunisti, i quali tutti, sul presupposto errato della pretesa inferiorità della “civiltà contadina”, incapace di svolgere attività imprenditoriale agricola, ritenevano che fosse necessaria l’industrializzazione “dall’alto” per lo sviluppo del Mezzogiorno. I fatti successivi dimostrarono inequivocabilmente – osserva puntualmente il Russo – il fallimento dell’”industrializzazione senza sviluppo” con la conseguenza dello sperpero di migliaia di miliardi del denaro pubblico, rifluito nelle tasche di imprenditori del Nord, a volte improvvisati, di faccendieri e di veri e propri truffatori, spesso collusi con personale pubblico.
Ci volle il terremoto del novembre 1980 per scoprire – scrive il Russo – “l’esistenza della civiltà contadina dell’Irpinia e della Lucania, sotto i ruderi delle masserie e dei borghi contadini dai nomi ormai dimenticati, per ammettere che i contadini avevano dimostrato (quelli che non erano emigrati) capacità imprenditoriali autonome nelle imprese agricole e nelle piccole e medie aziende artigianali molto più dei luigini, maestri di scuola o impiegati comunali. Il rapporto che Manlio Rossi Doria scrisse sulle condizioni dei paesi del cratere, confermava anche sul piano tecnico ed economico, una scoperta: quella della energia autonoma delle “civiltà contadine”, che erano state considerate soltanto una scoperta poetica di Carlo Levi”. domenico.cassiano@libero.it