
di Domenico A. Cassiano
Alla fine degli anni Sessanta, don Giuseppe era un giovane sacerdote di rito greco, incaricato dell’insegnamento di Religione nelle classi ginnasiali del Liceo classico di San Demetrio Corone, dove io insegnavo Storia e Filosofia.
Lo conoscevo poco e ritenevo che fosse solo uno dei tanti sacerdoti impegnato nel puro e semplice esercizio della sua funzione, come lo erano tanti altri della sua Diocesi. Eravamo – allora – tutt’e due giovani e, nelle ore d’intervallo dell’insegnamento, avevamo l’occasione di conversare e di scambiarci le nostre opinioni su argomenti vari, oltre che in genere di cultura, anche di politica. Mi accorsi che, su molte questioni, con eccezione di quelle di carattere religioso, ma particolarmente su quelle di carattere politico e sociale, le nostre opinioni coincidevano. Questo fatto gradualmente fu determinante nel mutare la nostra semplice conoscenza in vera e propria amicizia.
Un giorno mi cercò durante l’intervallo delle lezioni per propormi di collaborare alla redazione di una rivista che egli aveva intenzione di fondare; mi sollecitò di fargli avere un mio articolo che io gli consegnai dopo alcuni giorni e che avevo intitolato “Di archeologia a Sibari si muore”. Era, all’epoca, assai dibattuto l’affare della trasformazione industriale della Piana di Sibari. Il compianto senatore socialista Gino Bloise – che era anche poeta oltre che un prestigioso esponente socialista – sognava la Sibari del petrolio col suo cuore antico e, cioè, la Piana di Sibari trasformata in operoso centro industriale con la nascita di una classe operaia, col suo porto, come centro propulsore di una moderna vita civile, che avrebbe dovuto rinnovare lo splendore della mitica Sibari greca.
Sostenevo in quell’articolo, pienamente condiviso da don Giuseppe, che l’industrializzazione della Piana con la creazione di una classe operaia restava un pio desiderio e che la scoperta della Sibari antica non avrebbe creato quei posti di lavoro sperati, con la conseguenza che il biblico esodo emigratorio che andava spopolando i nostri paesi e la stessa regione sarebbe purtroppo continuato. L’improvviso interesse per l’archeologia era il cavallo di Troia per distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali e drammatici del momento, che erano poi quelli di sempre. Uscì, così, il primo numero di Zjarri, ciclostilato da don Giuseppe perché non aveva il denaro per pagare la tipografia. Qualche giorno dopo, mi cercò affannosamente don Giuseppe per mostrarmi il numero dell’Espresso, che aveva appena acquistato dall’edicola del compianto nostro amico Ambrosino e che, in un servizio da Sibari, in una delle pagine interne, pubblicava un articolo con lo stesso titolo del mio articolo, pubblicato nel primo numero ciclostilato di Zjarri: era una strana e fortuita combinazione. Fu questa una circostanza che lo stimolò e lo sostenne nell’impresa di continuare coraggiosamente nella pubblicazione della rivista, che, per la verità, mi sembrava velleitaria, proprio a causa della difficoltà di trovare le fonti di finanziamento.
Successivamente don Giuseppe riuscì – anche autofinanziandosi – a pubblicare la rivista con una certa regolarità, alla quale collaborai intensamente insieme ad altri, curando, per parte mia, le note politiche e, poi, quelle storiche. Con la rivista, esile ma spigliata, con scritti di varia ispirazione, ma anche di radicale contestazione, scevra da preoccupazioni o timori riverenziali, nasceva e si consolidava anche il mito del “prete rosso”, che indicava in don Giuseppe un prete “diverso” e innovatore, come non si era mai visto per il passato.
Molte volte, scherzando, quando mi pressava per avere il mio articolo, gli dicevo di smetterla dal fare il contestatore perché correva il rischio di essere sanzionato dai Superiori. Ma egli mi guardava ridendo quasi a volermi dire di stare tranquillo perché egli sapeva quel che faceva. Una volta, colsi l’occasione della pubblicazione della biografia di monsignor Francesco Bugliari per proporgli la mia recensione col titolo provocatorio di “Il Cristo giacobino di monsignor Francesco Bugliari”. Lesse l’articolo e mi disse di condividerlo e che si riprometteva di pubblicarlo nel prossimo numero. In effetti, quel numero della rivista destò un vespaio negli ambienti della curia vescovile, evidentemente attardata su sorpassate posizioni culturali. Lo stesso vescovo Giovanni Stamati, di recente nominato Eparca, che era persona colta, avveduta, aperta alle novità, incassò il colpo. Quel titolo di “Cristo giacobino” lo mise in una qualche difficoltà e dovette sollevargli una serie di dubbi se, alla prima occasione che mi incontrò, accennò all’articolo palesandomi la sua perplessità sull’intitolazione. «Ma quel giacobino avreste potuto evitarlo… forse era eccessivo», mi disse. Sciolsi ogni dubbio al Vescovo spiegandogli che, in Italia, il termine “giacobino” era un modo generico per designare un riformatore, un filofrancese e non era equiparabile al significato che il partito giacobino aveva assunto all’interno delle formazioni rivoluzionarie francesi. Ed il Vescovo Bugliari era sicuramente un illustre riformatore tanto che Giuseppe Maria Galanti lo aveva proposto al re di Napoli come presidente dell’istituendo Collegio della società patriottica della Calabria settentrionale; assassinato dal brigantaggio filoborbonico, la sua morte fu considerata come avvenuta “in servizio del Re e della Patria”, cioè, in difesa del governo napoleonico.
Ebbi, allora, modo di comprendere che don Giuseppe non era “un pidocchio di Cristo” e, cioè, un semplice impiegato della Chiesa; sotto l’apparenza di una certa levità nei comportamenti, aveva maturato un suo profondo convincimento, che lo distingueva e distanziava da altri suoi colleghi della Eparchia lungrese: fermo nella credenza e nella affermazione dei principi evangelici, era anche profondamente convinto che, sotto il profilo pratico e politico, le lotte per la giustizia, per l’uguaglianza, per l’attuazione dei principi della nostra Costituzione, contro le discriminazioni, non erano in contrasto con il Cristianesimo.
Come don Milani, don Primo Mazzolari, don Minzoni e don Camilo Torres, egli riteneva che, da cristiano e da sacerdote, non poteva essere spettatore inerte di un sistema sociale che neghi alla maggioranza la possibilità ed il diritto ad una vita dignitosa, al lavoro, al mangiare, al vestire, all’istruzione, alla salute. Da qui il bisogno di confrontarsi e misurarsi con gli altri, di esternare attraverso il giornale e gli scritti questi suoi convincimenti e questi suoi ideali che erano religiosi perché traevano le loro fonti di ispirazione dai Vangeli, ma erano anche civili e politici proprio perché nella polis andavano riaffermati, attuati e difesi per il motivo che tali princìpi erano da considerarsi come sussidiari e non contrari a quelli evangelici.
Questo suo atteggiamento, che certamente dava nell’occhio e rompeva e sfatava una serie di pregiudizi sugli uomini di chiesa, era, peraltro, in coerenza con l’esempio e la prassi dei grandi vescovi italo-albanesi: il citato monsignor Bugliari ed il suo successore nella presidenza del Collegio italo-albanese di Sant’Adriano, il vescovo Domenico Bellusci.
Bugliari, inappuntabile sotto il profilo religioso per come evidenzia la sua Dissertatio theologico-critica, pubblicata a Napoli nel 1791, era, altresì, fermo nel suo convincimento e nei suoi propositi di rinnovamento e di riforma politica e sociale, spenti dal pugnale sanfedista. Bellusci, che insieme ad Angelo Masci, aveva sofferto il carcere al tracollo della Repubblica Napoletana nel 1799, sapeva nella pratica coniugare la sua fede cristiana, priva di fanatismo e di odio teologico, con le istanze di libertà e di rinnovamento. Fu durante la sua presidenza e al tempo della Restaurazione che Sant’Adriano divenne un laboratorio culturale, dove circolavano e si diffondevano tra gli studenti liberamente i testi delle “novità” culturali europee e l’insegnamento era improntato alla più grande apertura ai movimenti culturali europei contemporanei.
Nel carme funebre in morte del Bellusci, ricorda Domenico Mauro (1812-1873), alunno del Collegio in quell’epoca, che Monsignor Bellusci col suo carisma esercitava una straordinaria influenza sui discepoli:
“spingea l’anime nostre in su le penne /di sua voce possente in verso i regni / della Speranza e del Futuro un doppio / le accendendo desìo di essere eterne / qui nella terra e su nel cielo; e quando / con la solerte mano ei collocava / su la squallida tomba del Passato / una fiaccola viva che, sperdendo / le tenebre diffuse, a noi svelava / i secoli giganti circuenti / quella polvere antica…”

II
Don Giuseppe incarnava, nella prassi, lo spirito di questa tradizione di un cristianesimo tollerante, liberale, a volte addirittura libertario, che era caratteristica del clero di rito greco dei paesi albanofoni, uxorato o no, che, del resto, era stato estraneo al Concilio di Trento anche se, qualche volta, ne aveva dovuto subire il rigore controriformistico, particolarmente quando gli Ordinari diocesani latini scambiavano certe manifestazioni popolari per peccaminose e meritevoli, quindi, di repressione e di proibizione.
Questa tradizione, che si era consolidata nelle lotte antifeudali e che poteva anche contare sui grandi intellettuali della locale borghesia rurale, come Alessandro Marini, Angelo Masci, Pasquale Baffi, oltre che sullo stesso clero, trovò un potente strumento di conservazione, di affinamento e di trasmissione nel Collegio italo-greco, dove – ed è questo un fatto di estremo rilievo – venivano istruiti ed educati sia giovani vocati all’esercizio sacerdotale nel rito greco sia giovani che, dopo gli studi curricolari, sceglievano le professioni liberali.
Il giovane Giuseppe Gangale, che vi studiò nel primo quindicennio del ‘900, trovò che il “liceo-ginnasio ultra laico” e che la temperie “ultra laica” era espressa nel “rubicondo pope albano-greco ricco di figli e di terre e di reputazione” e nel docente di scienze, positivista e ateo, “famoso ai suoi tempi”.
Vi coesistevano, in effetti, senza conflittualità, la religiosità e lo spirito laico e liberale. Dopo l’emanazione del Sillabo, i docenti del Collegio, laici e sacerdoti, in una Memoria, indirizzata al Parlamento italiano, rivendicavano come prezioso patrimonio culturale il fatto che la Scuola di Sant’Adriano “propagava i princìpi di vera religione e di buona morale, preparando la gioventù albanese alle idee della crescente civiltà…Era scritto nei secoli nei decreti della Provvidenza che questo antico soggiorno delle muse non dovesse perire nella strage della reazione…”;
confidavano e si lusingavano che “il Capo della Chiesa…non farà desiderare a lungo la calma delle coscienze e scegliendo per sé il governo degli spiriti, abbandonerà volentieri le fastidiose cure della terra per fondare nel cuore degli uomini una Sede che non avrà mai fine”.
Questa tradizione era ancora viva nel 1923 quando La Calabria Fascista, organo provinciale del partito al potere, è costretta, in una nota del 16 marzo, a prendere atto, malvolentieri e con sorpresa, della inopinata ostilità del clero albanese e dell’ordine, impartito dall’Eparca della Diocesi greca di recentissima costituzione (1919), a tutti i sacerdoti della Diocesi di rifiutare la benedizione dei gagliardetti fascisti.
Ben presto, però, il vescovo di Lungro fece marcia indietro allineandosi agli altri vescovi calabresi che il 13 gennaio 1923, nella prefettura di Reggio Calabria, avevano reso omaggio al duce ed in occasione della raccolta del cosiddetto “oro per la patria” offrirono le croci pettorali.
La massima istituzione ecclesiastica della comunità albanofona – come mai era accaduto in precedenza – si incamminava a scambiare la tonaca con la camicia nera, anche se singoli sacerdoti si impegnarono attivamente contro la dittatura, come, per esempio, quel sacerdote – ricordato da Andrea Croccia – che era “di una famiglia comunista” ed “ha fatto un buon lavoro ed è stato un bravo collaboratore” nello smistare materiale propagandistico nei paesi al confine tra la Calabria e la Basilicata.

Le annate del Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di Lungro attestano la progressiva deriva littoria del vescovo, che incominciò col festeggiare la Conciliazione con “una solenne funzione di ringraziamento nella Cattedrale”, pronunziando un roboante discorso e, quindi, con accompagnamento di popolo e autorità “all’Episcopio inneggiando al Papa, al Re, al Duce, all’Italia, tra i concenti della banda musicale”.
Seguirono innumerevoli altre cerimonie:
“Avanguardisti in divisa prestavano servizio d’onore” nelle funzioni religiose e gli inni fascisti si confondevano con i canti religiosi.
“Commoventi gli inni sacri cantati con grande ardore e voci squillanti dai Balilla e dalle Piccole Italiane” – è scritto in una delle tante similari cronache, apparse in quegli anni nel citato Bollettino diocesano.
Il numero 44 del 1935 del Bollettino riporta il discorso del vescovo contro il deliberato del Consiglio della Società delle Nazioni che – è scritto – “mentre in teoria riconosce all’Italia il diritto di espandersi in pratica glielo nega; mentre riconosce che nell’Etiopia persistono la schiavitù e la disorganizzazione civile e sociale, vuole impedire all’Italia la sua opera di civilizzazione”.
In difesa della politica di aggressione del fascismo, prosegue denunziando “gli interessi britannici della plutocrazia e dell’imperialismo e congiurano insieme la massoneria e il bolscevismo che temono di un’Italia più forte e più grande”.
Confonde le “massime dell’Evangelo” con le pretese ragioni dell’imperialismo fascista, assumendo che non era “equo” che uno Stato come l’Etiopia “semifeudale…possegga un territorio quattro volte più grande di quello di uno Stato di civiltà millenaria con una popolazione quadrupla ed esuberante”.

Il vescovo si unirà al duce nell’inneggiare all’impero “sui colli fatali” nel suo discorso di ringraziamento per la vittoria imperiale e “per l’annessione dell’Etiopia…e la fondazione o dopo tanti secoli rifondazione dell’Impero Italiano o Romano o Fascista…per l’aiuto di Dio Onnipotente, per l’ardente fede e l’indomita volontà del Duce…”.
Facendosi profeta della perennità del fascismo, proclamerà solennemente dal pulpito:
“Questo periodo di tempo che noi abbiamo la fortuna di vivere costituirà per i posteri una pagina d’oro nella storia d’Italia, forse la pagina più bella e più gloriosa e più feconda di bene”.
Neppure lo sfiora il dubbio dell’essenza fondamentalmente anticristiana, violenta e pagana della teoria e della prassi fascista. Vuole celebrare, inoltre, la “triplice vittoria dell’Italia: militare, morale e politica…e rendere grazie a Dio che ha visibilmente tra mille e mille ostacoli protetto l’Italia, protetto il Re, il Duce e l’esercito”. E, finalmente, indossando la camicia nera, conclude pregando “Iddio che ci conceda una quarta vittoria, la vittoria diplomatica, che cioè nei prossimi giorni o nelle prossime settimane tutte le altre Nazioni riconoscano il fatto compiuto, riconoscano la decretata e irrevocabile annessione dell’Etiopia all’Italia e deliberino la cessazione delle inique sanzioni, onde la giusta pace apra candida le sue ali sull’Europa e sul mondo intero e una nuova era di verace progresso si dischiuda per tutti gli uomini”.
Dopo l’effimero accordo di Monaco, con circolare del 30 settembre 1938, invita i parroci a cantare “in tutte le Chiese l’inno di ringraziamento o grande Dossologia, esposto solennemente il Santissimo”, per lo scampato pericolo della guerra, rilevando che “l’intervento del Duce è stato provvidenziale, tempestivo e decisivo”. Sulla abominevole legislazione razzista di quell’anno, il silenzio è assoluto.
Il 29 marzo 1939, per la “presa di Madrid”, nella cattedrale, cantò la “grande Dossologia” e impartì la “solenne benedizione col Venerabile” e tenne un discorso per evidenziare che “le forze nazionali e legionarie” avevano conquistato Madrid “dopo la resa senza condizioni dei rossi”; che “ventitrè milioni di uomini sono stati liberati dalla velenosa e terrificante tirannide del bolscevismo”; che il generale Franco ed “un pugno di generosi”, in difesa della fede e della religione, “in sul principio furono animati e spinti alla guerra nazionale, alla guerra liberatrice, alla guerra d’indipendenza”.
Non mancò dal rilevare nel pistolotto finale che “il trionfo del Caudillo e dei nazionali spagnoli è anche trionfo del Duce e dei legionari italiani”; invitò, infine, i Lungresi “in quest’ora di esultanza” ad innalzare “a Dio Onnipotente l’inno di lode e di ringraziamento”.
Il 24 aprile 1939, dopo l’occupazione italiana dell’Albania e l’offerta, da parte di un pugno di traditori, della corona albanese al re d’Italia, scriveva ai parroci che “tale deliberazione riempie di gioia tutti gli italiani in generale e di noi italo-albanesi in particolare. Così le nostre sorti saranno sempre più intimamente unite con quelle dei nostri fratelli d’oltremare, i quali d’ora innanzi saranno più felici e faranno rapidi progressi nelle vie della cultura e della civiltà…”. Invitava i parroci a suonare “le campane a festa in tutte le Chiese ed esposto solennemente il Santissimo si canti la grande Dossologia”.
Non considerò affatto che con la forzata annessione all’Italia, l’Albania perdeva la propria indipendenza. Se, infatti, parte degli esponenti della comunità cattolica albanese si allineò al nuovo regime, forte fu l’opposizione espressa dallo stesso Delegato Apostolico monsignor Nigris, che considerò l’azione bellica italiana un vero, reale attacco all’indipendenza albanese.
Don Giuseppe, non contaminato dalla retorica e da ogni sorta di trionfalismo, ebbe anche la ventura di incontrare, nello svolgimento della sua azione sociale e culturale, il successore del vescovo a cui dianzi ho accennato, monsignor Giovanni Stamati, che aveva intrapreso un’opera di rinnovamento in seno alla Diocesi e di riprìstino – compatibilmente con le esigenze e le istanze dell’epoca – della tradizione tipica del rito greco, in aderenza ai canoni della Chiesa di rito greco, adoperandosi per la purezza del rito, facendo anche tradurre nella parlata locale i testi liturgici e paraliturgici. Non gli era neppure mancato il coraggio, pagando di persona ed in silenzio, quando, in momenti delicati e difficili, anche di fronte alle aperte riserve ed opposizioni da parte delle gerarchie ecclesiastiche egemoni del rito latino, colse l’opportunità di ripristinare il matrimonio per i sacerdoti greci, per come, del resto, stabilivano i canoni – mai abrogati – della chiesa di rito greco.
Don Giuseppe, nella qualità di membro attivo della Chiesa di rito greco, fu partecipe degli sforzi e delle azioni di ammodernamento ecclesiale, predisposti e sollecitati da monsignor Stamati. Il suo attivismo, che lo portò ad essere animatore ed organizzatore culturale, si espandeva anche oltre l’ambito ecclesiastico, toccando l’ambito socio-politico ed, in questo contesto, privilegiando la cultura dei gruppi etnici minoritari, particolarmente, quello arbresh. Il tema delle minoranze etnico-linguistiche trovava invero un proprio riconoscimento esplicito nella disposizione normativa dell’articolo 6 della nostra Costituzione, ma solo allora veniva imponendosi come “scoperta” a seguito dei movimenti democratici popolari e del progresso delle ricerche e degli studi antropologici e linguistici.
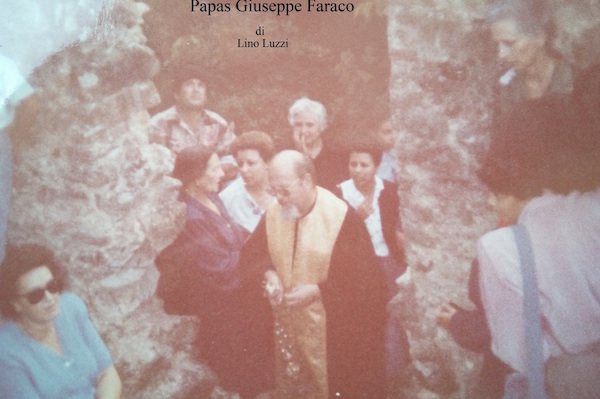
III
Don Giuseppe, facendo tesoro della “novità” della lingua arbreshe, introdotta nella celebrazione della messa e delle altre funzioni religiose, introdotte per impulso del vescovo Stamati, aveva compreso tutta la complessità culturale e latamente politica della tutela della cultura minoritaria, che consisteva e nel garantire l’identità etnico-linguistica e, contestualmente, il necessario processo di integrazione – e non di assimilazione – nella più vasta comunità nazionale. Né più e né meno di quello che aveva fatto il Vescovo Stamati, facendo celebrare la messa nella lingua parlata dal “popolo di Dio” e, nello stesso tempo, facendo opera di integrazione della Chiesa di rito greco nell’ecumene ecclesiastica, così preservando l’identità etnico-linguistica della comunità arbreshe nell’ambito vasto dell’ecumene cattolico.
L’aveva perfettamente capito un intellettuale italo-albanese quando, ironizzava scrivendo che “Don Giuseppe Faraco…farakòn”, parlava, cioè, un linguaggio che si differenziava dal volgare e asfittico folklore, ma aveva una sua precipua e radicale valenza.
Quale fosse questa valenza specifica è presto detto: essa era il superamento della prassi anteatta della identità-emarginazione per pervenire alla identità-integrazione. E, cioè, la comunità locale, analfabeta “zoppa” nella propria lingua in quanto la parlava, ma non sapeva scriverla, avrebbe dovuto appropriarsene attraverso “una alfabetizzazione di massa in albanese a livello di scuola materna, elementare e di scuola media accanto alla alfabetizzazione in italiano… questo processo di alfabetizzazione in albanese” presupponeva “un più vasto processo di coscientizzazione, cioè di una presa di coscienza dei valori culturali autentici della comunità italo-albanese”.
Il termine “coscientizzazione” voleva indicare “il metodo pedagogico che cerca di dare all’uomo l’opportunità di riscoprirsi attraverso la riflessione sul processo della sua esistenza. La coscientizzazione è così lo sviluppo critico della presa di coscienza. Questa presa di coscienza critica e autoriflessiva comporta l’esigenza di determinare quali sono i valori autentici da promuovere”.
Zjarri, la rivista ideata e diretta da don Giuseppe, svolse la duplice funzione di:
a) promozione della conoscenza della lingua parlata dal popolo; e b) di “riscoperta” della reale storia civile e religiosa della comunità.
Ebbe, cioè, come sottolineò lo stesso don Giuseppe, “una funzione di serio impegno culturale, di revisione e di smitizzazione della “cultura ufficiale” italo-albanese, rappresentata, con le debite eccezioni, da una certa intellighenzia troppo indaffarata nel recupero libresco delle tradizioni, nel lanciare reiterati e “confezionati” appelli e proclami dalle colonne dei giornali locali, senza fare poi concretamente nulla per la salvaguardia effettiva delle tradizioni… ciò favorisce, in certo modo, un chiaro disegno che tende a fare svolgere agli Italo-albanesi il ruolo non certamente nobile e serio di “riserve” folkloristiche esotiche alla maniera di quelle degli Indiani d’America per richiamo di turisti”.
L’ambizione o, se si vuole, l’utopia di don Giuseppe era quella “di arginare i danni prodotti dalla miopia e dai limiti culturali evidenziati a livello di dirigenza scolastica e politica che ha fatto sì che migliaia di ragazzi fossero educati nell’ignoranza di sé stessi sino a farli vergognare di parlare la lingua dei loro genitori e arrossire delle proprie origini popolari, contadine o montanare, e ridurli a stranieri nella loro terra. La scuola tradizionale perpetua il genocidio delle culture “altre” come quella albanese, che potrebbe divenire alternativa…Perciò…l’unico rimedio contro l’assimilazione e la conseguente nostra sparizione…sia l’insegnamento della lingua albanese: che ogni albanese diventi un perfetto bilingue. Accanto alla lingua e alla cultura italiana egli deve possedere in eguale misura e livello anche la lingua e la cultura albanese”.
L’impostazione di don Giuseppe aveva, dunque, una chiara e conseguente valenza politica – anche se Egli non era un politico – dal momento che riteneva – ed era questa una assoluta novità rispetto al passato di tanti “cultori” che si erano dilettati nella ricerca di nobili e aristocratiche ascendenze – che esisteva un popolo di contadini e montanari analfabeti, cioè, di fatto, che si trattava di una comunità contadina, in favore della quale bisognava adoperarsi per riscattarla dalla identità-emarginazione, alla quale per secoli era stata condannata e che, per la sua storia contrassegnata da un sogno di liberazione, non meritava di essere considerata alla stregua di una riserva indiana.
Non era una utopia, ma un disegno consapevole e preciso di assumere e partire dal connotato sociale della minoranza linguistica come comunità contadina. Partendo da questo oggettivo presupposto di fatto, bisognava dare risalto agli elementi strutturali per pervenire e sviluppare un processo di emancipazione e di pieno inserimento e di dignità nella cultura nazionale, che allora si avviava a prendere connotati urbano-industriali, considerando il mondo o la civiltà contadina come arcaico, arretrato e, quindi, da superare e cancellare.
Don Giuseppe non sognava e non inseguiva l’utopia. Il suo progetto, che avrebbe richiesto per la sua realizzazione anche necessari interventi politici, per le sue articolazioni e per le finalità, non era campato in aria. Egli l’utopia – per come esplicitato in un numero della rivista – la lasciava ai sognatori: “la società realizzabile è quella della nostra speranza, quella che può migliorare tutti i giorni”.
Zjarri fece il suo lavoro di scavo sul piano politico-culturale, portando alla luce gli autentici valori della comunità arbreshe, evidenziando le pregresse battaglie civili combattute per il rinnovamento sociale e per la salvaguardia della specificità religiosa, individuando anche gli intellettuali che, nei secoli, tali lotte avevano impersonato, rivelando e provando il rilevante contributo che la minoranza albanofona aveva dato alla crescita civile e politica del Mezzogiorno proprio nei momenti cruciali di tali lotte, battendosi per la repubblica sin dalle rivolte del 1647-48, partecipando attivamente a quelle per l’affermazione dei princìpi di libertà, uguaglianza e fratellanza del 1799, sostenendo nel Decennio francese l’opera di rinnovamento politico-amministrativo, organizzando durante la Restaurazione i moti per l’indipendenza ed, anzi, con la rilevante partecipazione della popolazione di contadini e di intellettuali e del clero ne rappresentò l’avanguardia democratico-repubblicana, fino alla scelta repubblicana pari al 60% del suffragio nel referendum del 1945 e, poi, all’epopea popolare della occupazione delle terre nel secondo dopo-guerra.
In buona sostanza, Zjarri, sia pure con mezzi modesti, sfatò le leggende ed i miti di un popolo di nobili guerrieri, progressivamente portando alla luce la dura realtà di una popolazione che, faticosamente dalla precarietà e dalle condizioni di miseria dei primi insediamenti, seppe guadagnarsi la dignità di uomini; dall’umiltà di profughi, parificati nel Mezzogiorno ai servi della gleba, pervenne all’integrazione fino al protagonismo nella vita civile e sociale della Nazione;
dall’analfabetismo e dall’ignoranza alla luce del pensiero letterario, giuridico, filosofico ed economico, attraversando la difficile coesistenza religiosa, le lotte antifeudali, il passaggio del feudalesimo al Comune, il giacobinismo, il Decennio francese, le lotte risorgimentali, la questione demaniale, il fascismo e l’antifascismo fino al voto repubblicano.
Un problema irrisolto – ed anche di assai difficoltosa soluzione – resta quello della stessa sopravvivenza della lingua. Particolarmente oggi, dopo il fallimento “dell’industrializzazione senza sviluppo” – per dirla con le parole di Giovanni Russo – le cui conseguenze hanno portato al pauroso svuotamento dei paesi, all’esodo biblico delle masse rurali, alla rottura degli equilibri sociali, alle discriminazioni ed all’aumento delle disuguaglianze, alla disintegrazione del mondo contadino con la scomparsa e la caduta degli antichi valori ed il sopravvento dell’egoismo e del consumismo più sfrenato che ha trasformato in senso negativo le relazioni sociali e politiche.
Ora se i paesi si svuotano perchè le strutture economiche delle antiche comunità, diventate assai fragili, non riescono a resistere ed a sopravvivere al processo dell’economia, una comunità senza popolo viene meno ed anche la lingua è costretta ad un malinconico processo di progressiva perenzione. redazione@altrepagine.it